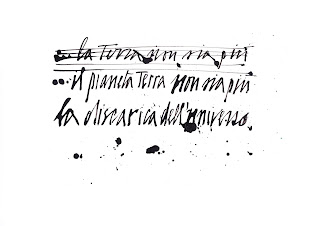Carlo Pava
contrattacco disarmato
1973
3

Sulla copertina del quaderno una
figura, forse una ragazza o forse un ragazzo, allora si usava così, unisex, in
primissimo piano, in stile psichedelico, con i colori accesi o chiassosi con
accostamenti non raffinati, pop art, il rosa confinante con il verde e con
l’arancione [l’arancione, hare krishna hare krishna hare hare, nel suono dei
tamburelli], insieme all’invadenza del blu
metallico, il volto rivolto verso l’alto in segno di misticismo da
droga, ampliando la coscienza, ma anche no, il contrario, la santità della vita
parsimoniosa e della macrobiotica. Il monastero, sì, se era rigorosamente
buddhista. Ahi Ahi Ahi, povero me, stavo fuori giro, refrattario alla
gestualità corale [una vera e propria idiosincrasia, compreso il segno della
croce quando andavo a messa fino ai 14 anni, durante la mia “azione cattolica”,
poi basta]. E se in tarda età pensavo a un convento… era un convento per
agnostici, per la Casta Anaffettiva, per l’Ordine dei Vecchi Disillusi, quelli
che avevano sempre creduto nel disamore.

Sul frontespizio l’immagine era
la stilizzazione dei più noti stilemi grafici del Liberty, già stilizzato di
suo in origine, non male: la psichedelia che furoreggiava sulle copertine dei
dischi pop e rock [non so se mi esprimo bene] a volte appariva come una sua
ripresa aggiornata ma made in San Francisco, basta con i parapetti d’Europa di
Arthur Rimbaud, non eravamo più eurocentrici, lo dimostravano le basi militari
della NATO in Italia e la canzonetta di Renato Carosone: “Tu vuo’ fa’
l’americano/… puorte ‘e calzune cu nu stemma arreto/… tu vuoi vivere alla moda/
ma se bevi whisky and soda”. Uh, l’whisky andava ancora bene per il salotto del
PCI di Madame X [Greta], noi giovani avevamo altre esaltazioni indotte, altre
euforie, altre intossicazioni, soft e hard.
Ma non bisognava prendermi troppo
sul serio: chi ero io, e chi sono, per permettermi di alludere alla vera storia
sociale di quegli anni, uno studio riservato agli specialisti, prendere o
lasciare [senza punto interrogativo]: mi limitavo a raccontare tanto per
raccontare le sequenze oniriche tracciate in forma di appunti rielaborati a
distanza di quasi mezzo secolo. Tanto per citare Luigi Pirandello: Uno,
Nessuno, Centomila [Franz].

Il quaderno n. 20, un quadernino
per scolari e studentini dei più comuni, comprato in una cartoleria, con le
date 24 novembre 1972 – 23 aprile 1973, quindi ne avevo tanti altri che lo
precedevano e lo seguivano: [se non ci credete potrei giurarlo]. Ormai la
psichedelia veniva accettata a livello superficiale, senza che il pubblico
piccolo-medio dei consumatori se ne rendesse conto. E i capelli lunghi e le
camicie con i colletti troppo grandi e le maniche troppo strette e i calzoni a
zampa d’elefante. E le ragazze con i vestiti da zingara. Il Viaggio in India. E nei supermercati,
reparto libri, si trovava già Allen Ginsberg nei tascabili: il mio autore
preferito dopo PPP, ero un loro fan.
Mi ripromettevo di evitare la
fotografia tradizionale, i paesaggi [compresi i paesaggi urbani] con qualcosa
in primo piano, sia pure un dettaglio, per dare l’idea della profondità di
campo, il campo lungo o il campo lunghissimo, la dimensione prospettica. Ma,
riscrivendo nel 2088, ogni tanto incappavo con gli avvenimenti fastidiosi della
politica che avrebbero potuto allungare le loro ombre nel lontano passato, per
cui avrei fatto fatica a tacere su alcuni punti. L’immagine: una mano
gigantesca e scura, nel disegno non troppo dettagliata, su un mappamondo.
Imperversava una famosa pandemia,
ma dai risvolti dubbi, non si sapeva ancora bene se particolarmente letale,
assai più delle normali influenze stagionali che di norma causavano molte morti
soprattutto fra la popolazione con altre patologie gravi. Ma addirittura si
insinuava che poteva trattarsi della battaglia di una guerra batteriologica scatenata
dall’Oligarchia che in quegli anni dominava il Globo, vox populi, la doxa
alternativa o dissidente. Le autorità pensavano ai danni economici e alla
ripresa delle attività e della ricostruzione dopo un lungo periodo di
quarantena, questa parola pervertita, da quaranta i giorni erano diventati due
mesi, tre mesi, non si sapeva più bene fino a quando.

Il contagio, causato da un virus
di cui non ricordavo più il nome, ce n’erano tanti nelle polveri sottili che
respiravamo nel traffico automobilistico, capitava a proposito in un’epoca in
cui si stavano studiando vari modi per diminuire la popolazione che si
attestava fra i 7 e gli 8 miliardi [alla quale poco interessava le sorti della
ricerca poetica]. Però invitatemi alla brevità, una digressione può essere
calzante ma senza dilungarsi troppo, da sviluppare in altri libri. Per farla
breve: le autorità stavano studiando il modo per permettere di uscire di casa a
scaglioni, ossia per liberare dagli arresti domiciliari queste o quelle
categorie di sudditi. Gli over65 apparivano in tutta ovvietà i meno favoriti,
già da decenni e decenni ci si era pentiti di averli mantenuti con i progressi
della medicina e l’efficacia dei farmaci, l’aspettativa di vita esageratamente
aumentata, si stava prospettando un nuovo delitto da definire in una
commissione parlamentare: la vecchiaia, che poteva richiedere il ripristino
della pena capitale. Bisognava dare un taglio. Intanto venivano relegati nelle
proprie abitazioni molto più degli altri. Qualcuno, fra i più paranoici, temeva
che prima o poi sarebbe arrivato un Addetto del Comune per eliminarci con il
gas domestico.
 Chi paventava l’obbligo di un
vaccino, sospettando che ci mettessero l’arsenico per ammazzare i pensionati.
Chi si riteneva sicuro che ci avrebbero graffettato l’etichetta di “potenziale
untore” sull’orecchio destro, ignorando che la tecnologia più attuale aveva già
un’app sul cellulare, detta “immuni”, per monitorare chiunque. E si sapeva
benissimo che prima o poi avrebbero innestato in tutti un microchip per mappare
gli esseri umani dalla nascita alla morte. Tra i ribelli d’ogni età, non ancora
usciti allo scoperto come agit-prop, si insinuava a poco a poco un movimento di
neo-luddismo, non disarmato, tutt’altro, per sabotare tutti i nuovi strumenti
del controllo sociale finalizzati all’eliminazione della libertà individuale,
il concetto di libertà tanto analizzato dalla filosofia in ogni civiltà d’ogni
epoca e a qualsiasi livello di cultura. Intanto appariva la propaganda delle
autorità locali e il suo détournement.
Chi paventava l’obbligo di un
vaccino, sospettando che ci mettessero l’arsenico per ammazzare i pensionati.
Chi si riteneva sicuro che ci avrebbero graffettato l’etichetta di “potenziale
untore” sull’orecchio destro, ignorando che la tecnologia più attuale aveva già
un’app sul cellulare, detta “immuni”, per monitorare chiunque. E si sapeva
benissimo che prima o poi avrebbero innestato in tutti un microchip per mappare
gli esseri umani dalla nascita alla morte. Tra i ribelli d’ogni età, non ancora
usciti allo scoperto come agit-prop, si insinuava a poco a poco un movimento di
neo-luddismo, non disarmato, tutt’altro, per sabotare tutti i nuovi strumenti
del controllo sociale finalizzati all’eliminazione della libertà individuale,
il concetto di libertà tanto analizzato dalla filosofia in ogni civiltà d’ogni
epoca e a qualsiasi livello di cultura. Intanto appariva la propaganda delle
autorità locali e il suo détournement.
In varie città proliferavano le
scritte sarcastiche accanto alle statue di Mr Pasquino, democraticamente
tollerate e ubicate in un angolo delle piazze principali, e i graffiti del
seguente tenore: “Non avete ancora progettato i nuovi forni crematori per
anziani e malati? Ci avete pensato e state prendendo tempo per organizzarvi? Li
state commissionando alle ditte del vostro entourage e uniche appaltatrici
consultate di centro-destra di sinistra e di centro-sinistra di destra?”.
 Il rispetto per le regole del
vivere civile e il senso di responsabilità : ma anche giù la maschera
dell’ipocrisia. Stavano dicendo agli over65 di restare in casa più a lungo
degli altri per limitare il numero delle persone in giro per strada e sui mezzi
di trasporto. Di fatto stavano discriminando una parte di popolazione come se
fosse una razza da deportare nei nuovi campi di concentramento [ossia ognuno
nel proprio domicilio]. E peggio: stavano obbligando ad avere un’app [“immuni”]
per distanziare i cittadini italiani [restii a sottomettersi a tali abusi] dai
connazionali più favoriti dalla sorte e più disinvolti con le nuove tecnologie,
meno disillusi. Forse perfino qualcosa di più sordido in prospettiva futura: un
microchip dalla nascita alla morte secondo il ribaltamento diabolico dello
Stato Sociale sempre più disgregato [una concessione al linguaggio
giornalistico]. Un surplus: infatti, sarebbe stato più semplice controllare
tutti dal punto di vista sanitario, così i sani con il patentino di buona
salute avrebbero potuto circolare liberamente e i malati li si sarebbe potuti o
dovuti curare. Ma tutto questo, così naturale e democratico, avrebbe avuto
costi troppo elevati e la sanità privata non se lo sobbarcava: gli affari erano
affari e sacrosanto l’accumulo della ricchezza in mano a pochi secondo i
parametri dell’universo neo-concentrazionario.
Il rispetto per le regole del
vivere civile e il senso di responsabilità : ma anche giù la maschera
dell’ipocrisia. Stavano dicendo agli over65 di restare in casa più a lungo
degli altri per limitare il numero delle persone in giro per strada e sui mezzi
di trasporto. Di fatto stavano discriminando una parte di popolazione come se
fosse una razza da deportare nei nuovi campi di concentramento [ossia ognuno
nel proprio domicilio]. E peggio: stavano obbligando ad avere un’app [“immuni”]
per distanziare i cittadini italiani [restii a sottomettersi a tali abusi] dai
connazionali più favoriti dalla sorte e più disinvolti con le nuove tecnologie,
meno disillusi. Forse perfino qualcosa di più sordido in prospettiva futura: un
microchip dalla nascita alla morte secondo il ribaltamento diabolico dello
Stato Sociale sempre più disgregato [una concessione al linguaggio
giornalistico]. Un surplus: infatti, sarebbe stato più semplice controllare
tutti dal punto di vista sanitario, così i sani con il patentino di buona
salute avrebbero potuto circolare liberamente e i malati li si sarebbe potuti o
dovuti curare. Ma tutto questo, così naturale e democratico, avrebbe avuto
costi troppo elevati e la sanità privata non se lo sobbarcava: gli affari erano
affari e sacrosanto l’accumulo della ricchezza in mano a pochi secondo i
parametri dell’universo neo-concentrazionario.
 Ma al tempo che fu, noi, la
popolazione, eravamo ingenui, in senso etimologico, nati liberi, o almeno lo
credevamo, non ancora del tutto manipolati dai mass media, e avevamo il massimo
rispetto per i libri, compravamo le novità, non solo i capolavori d’ogni epoca
e d’ogni civiltà. Fra gli appunti scritti con una penna stilografica nel
quaderno citato trovavo anche molte banalità, p. e.: “Devo ricordarmi che si
vive una volta sola e che il tempo passa in fretta: non sono venuto al mondo
per essere schiavo di tutto e di tutti, non nego gli slanci che mi passano per
la mente”. E subito dopo: “Non voglio essere una barca con le vele ammainate in
un porto [George Gray nell’‘Antologia di Spoon River’]. Non farsi sopraffare
dall’ignavia, avere coraggio”. In tutta evidenza ne avevo posseduto un’edizione
Einaudi, me la ricordavo, l’avevo prestata chissà a chi e mai più restituita
[anche questo un classico], le poesie di Edgar Lee Masters fatte conoscere in
versione italiana da Fernanda Pivano tramite Cesare Pavese. Per altri dettagli
avrei dovuto soffermarmi con qualche ricerca, non avendo il volume sottomano.
Ma al tempo che fu, noi, la
popolazione, eravamo ingenui, in senso etimologico, nati liberi, o almeno lo
credevamo, non ancora del tutto manipolati dai mass media, e avevamo il massimo
rispetto per i libri, compravamo le novità, non solo i capolavori d’ogni epoca
e d’ogni civiltà. Fra gli appunti scritti con una penna stilografica nel
quaderno citato trovavo anche molte banalità, p. e.: “Devo ricordarmi che si
vive una volta sola e che il tempo passa in fretta: non sono venuto al mondo
per essere schiavo di tutto e di tutti, non nego gli slanci che mi passano per
la mente”. E subito dopo: “Non voglio essere una barca con le vele ammainate in
un porto [George Gray nell’‘Antologia di Spoon River’]. Non farsi sopraffare
dall’ignavia, avere coraggio”. In tutta evidenza ne avevo posseduto un’edizione
Einaudi, me la ricordavo, l’avevo prestata chissà a chi e mai più restituita
[anche questo un classico], le poesie di Edgar Lee Masters fatte conoscere in
versione italiana da Fernanda Pivano tramite Cesare Pavese. Per altri dettagli
avrei dovuto soffermarmi con qualche ricerca, non avendo il volume sottomano.
 Il resto: l’amore che faceva rima
con il dolore. L’ambizione nel corso della vita e la pace nell’approssimarsi
della morte, da giovane. Prima o poi. Stavo prendendo il largo fra i venti del
destino restando impreparato? Accantonando il rincorrere il côté commerciale dell’editoria e
dell’inquadramento artistico [in cui ero del tutto inetto] o scegliere
l’underground, ecco, questa parola l’avevo usata forse per la prima volta in
quello stesso mese di gennaio. C’era la nebbia? Pioveva? Nevicava? La neve
cadeva lieve come nelle illustrazioni dei libri di scuola elementare su tutte
quelle tombe in collina. L’atmosfera per me più congeniale quando me ne stavo
nello studiolo al caldo per merito dei miei genitori già pensionati.
Innanzitutto lo scopo da individuare come un faro consisteva nel “fare” e in
secondo luogo nel collocare collocandosi nella dimensione più appropriata.
L’espressività personale, un tono da interpretare con difficoltà in quanto
derivante da uno specchio rotto, escluso dalla possibilità di indurre alla
sindrome di Stendhal. In prevalenza: la bruttezza, le brutture, la sporcizia
[compresa quella mentale], le ditate di unto sui fogli extra strong,
l’antigrazioso di Umberto Boccioni e del successivo Carlo Carrà [assai più
modesto], ne parlavamo con Silvano X [Franz], e a posteriori: Jean Dubuffet
derivava da là ma con assai maggiore respiro? Agli studiosi sarebbe spettato
gli studi specifici, senza fretta. E la via dei lettori? E la via del pubblico?
Cancellare tali pensamenti dall’orizzonte.
Il resto: l’amore che faceva rima
con il dolore. L’ambizione nel corso della vita e la pace nell’approssimarsi
della morte, da giovane. Prima o poi. Stavo prendendo il largo fra i venti del
destino restando impreparato? Accantonando il rincorrere il côté commerciale dell’editoria e
dell’inquadramento artistico [in cui ero del tutto inetto] o scegliere
l’underground, ecco, questa parola l’avevo usata forse per la prima volta in
quello stesso mese di gennaio. C’era la nebbia? Pioveva? Nevicava? La neve
cadeva lieve come nelle illustrazioni dei libri di scuola elementare su tutte
quelle tombe in collina. L’atmosfera per me più congeniale quando me ne stavo
nello studiolo al caldo per merito dei miei genitori già pensionati.
Innanzitutto lo scopo da individuare come un faro consisteva nel “fare” e in
secondo luogo nel collocare collocandosi nella dimensione più appropriata.
L’espressività personale, un tono da interpretare con difficoltà in quanto
derivante da uno specchio rotto, escluso dalla possibilità di indurre alla
sindrome di Stendhal. In prevalenza: la bruttezza, le brutture, la sporcizia
[compresa quella mentale], le ditate di unto sui fogli extra strong,
l’antigrazioso di Umberto Boccioni e del successivo Carlo Carrà [assai più
modesto], ne parlavamo con Silvano X [Franz], e a posteriori: Jean Dubuffet
derivava da là ma con assai maggiore respiro? Agli studiosi sarebbe spettato
gli studi specifici, senza fretta. E la via dei lettori? E la via del pubblico?
Cancellare tali pensamenti dall’orizzonte.
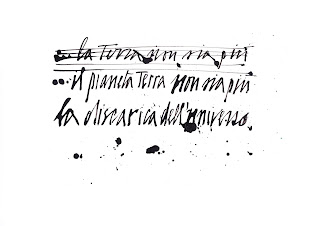 Finito l’effetto, il malessere.
L’equilibrio psicologico da ristabilire a intermittenze e in modo artificiale
non permetteva i progetti con grande apertura alare, non dico di un’aquila ma
nemmeno di una poiana o di un gabbiano: avrei preferito un avvoltoio, più
malvagio nell’immaginario. Le opere restavano in sospeso, ideate e bacate, una
cassettiera tarlata, incombevano come colombe nere svolazzanti nello studiolo,
mancava la fede nella loro necessità interiore e soprattutto la consapevolezza
dell’indifferenza a proposito della nostra presenza nel mondo. Avevo [quasi]
tutta la vita davanti a me ma appariva inutile, aveva il marchio del superfluo.
In tilt: la biglia del biliardino elettrico ferma in un punto del piano
inclinato, magicamente calamitata, occorreva uno scossone al trabiccolo, così
avrebbe potuto scendere e poi salire, una spinta decisa con un dinamismo a
zigzag. Mi restava la propensione per il frammentismo e l’incompiuto, le pagine
di piccolo formato per l’immediatezza delle realizzazioni e del rigetto.
Finito l’effetto, il malessere.
L’equilibrio psicologico da ristabilire a intermittenze e in modo artificiale
non permetteva i progetti con grande apertura alare, non dico di un’aquila ma
nemmeno di una poiana o di un gabbiano: avrei preferito un avvoltoio, più
malvagio nell’immaginario. Le opere restavano in sospeso, ideate e bacate, una
cassettiera tarlata, incombevano come colombe nere svolazzanti nello studiolo,
mancava la fede nella loro necessità interiore e soprattutto la consapevolezza
dell’indifferenza a proposito della nostra presenza nel mondo. Avevo [quasi]
tutta la vita davanti a me ma appariva inutile, aveva il marchio del superfluo.
In tilt: la biglia del biliardino elettrico ferma in un punto del piano
inclinato, magicamente calamitata, occorreva uno scossone al trabiccolo, così
avrebbe potuto scendere e poi salire, una spinta decisa con un dinamismo a
zigzag. Mi restava la propensione per il frammentismo e l’incompiuto, le pagine
di piccolo formato per l’immediatezza delle realizzazioni e del rigetto.
Non avevo più l’alibi delle
infatuazioni da adolescente, non convincevano più nemmeno a livello letterario,
l’innocenza dell’amore platonico post-adolescenziale veniva scalzata dalla
volgarità dopo il sessantotto, non ci si poteva più dedicare senza pensare al
ridicolo, neppure per un ritardato, per un buono a nulla su tutti i fronti in
cui mi ero difeso soprattutto da me stesso e soprattutto dagli altri [non so…
un’incongruenza, lasciamola tale e quale, le imperfezioni grammaticali e
sintattiche non guastavano, l’immediatezza e l’urgenza del comunicare a vuoto,
anche se per scrivere male bisognava saperci fare]. Un chiodo scacciava
l’altro, il loro aspetto belloccio, all’inizio idealizzato, nell’epoca della
lotta politica contro tutto, appariva comune a molti, alle commesse e ai
commessi dei supermercati. Nel cinema e in TV si cominciava a privilegiare
l’aspetto sgradevole o perfino peggio: più i personaggi [e gli attori] erano
brutti più venivano messi in mostra, il pubblico ci si riconosceva, erano come
noi tutti, people, e poi, soprattutto, i canoni cambiavano in fretta. E l’anormale
cos’era? E la norma? Chi decideva cosa? Il trasgressivo trascolorato in un
trasgressivo edulcorato e infine le femministe diventate “donne in carriera”
con i nuovi modelli di scarpe con tacchi a spillo, la loro anima, a detta di
una del loro genere.
 Fino al mio inquadramento
post-hippy, che però era un mix di pulsioni contrarie, nel 1973, il seguito
dell’andazzo vissuto quando il completo con cravatta [che si usava perfino da
ragazzini e da signorini di buona famiglia] veniva sostituito dal casual della
moda londinese che aveva abbandonato il twist. Privilegiavo il periodare
sincopato, ma non sempre o non spesso, lo ricercavo ma a volte stentava a
delinearsi. Uno stile spezzato o frantumato lo avrei considerato il massimo. Mi
limitavo a informare che anch’io uscivo di casa, con la bella stagione,
indossando i sandalini indiani, le ciabattine di cuoio che lasciavano i piedi
quasi tutti scoperti. Così, su indicazione di altri, avevo imparato un dato
essenziale: avevo i piedi di forma greca, con le seconde dita più lunghe degli
alluci, una rarità ma non un’anomalia, tutt’altro, un segno di distinzione, ne
ero orgoglioso.
Fino al mio inquadramento
post-hippy, che però era un mix di pulsioni contrarie, nel 1973, il seguito
dell’andazzo vissuto quando il completo con cravatta [che si usava perfino da
ragazzini e da signorini di buona famiglia] veniva sostituito dal casual della
moda londinese che aveva abbandonato il twist. Privilegiavo il periodare
sincopato, ma non sempre o non spesso, lo ricercavo ma a volte stentava a
delinearsi. Uno stile spezzato o frantumato lo avrei considerato il massimo. Mi
limitavo a informare che anch’io uscivo di casa, con la bella stagione,
indossando i sandalini indiani, le ciabattine di cuoio che lasciavano i piedi
quasi tutti scoperti. Così, su indicazione di altri, avevo imparato un dato
essenziale: avevo i piedi di forma greca, con le seconde dita più lunghe degli
alluci, una rarità ma non un’anomalia, tutt’altro, un segno di distinzione, ne
ero orgoglioso.
Le infatuazioni avrebbero potuto
servirmi per scrivere qualche poesia o, con maggiore ambizione, uno o più
romanzini. Un errore: dare importanza alla letteratura a scapito della vita
vissuta, mi pareva, idee nell’aria. Con Roberto X [Franz], ai tempi del mio
omicidio nella pubertà, mi ero fatto comportare come una Madame Bovary di
provincia [che esisteva in provincia fino alla morte], come una ninfetta di
periferia [citata a memoria, la lingua batteva tre volte sul palato, Lo-Li-Ta],
una Lolita non tanto smaliziata [trovandomi in una fiction diversa] e con
l’iniziazione più in tenera età rispetto a quella del film tratto dal romanzo
di Vladimir Nabokov, lo avrei visto in seguito e post mortem [la mia] [quello
originale, 1962, con la regia di Stanley Kubrik e con la protagonista Sue Lyon,
con il protagonista James Mason]. Però quello stesso anno, mentre io [ego]
stavo in pre-adolescenza, [quello, di alcuni anni più di me e ampiamente
adulto] aveva già letto il libro scandaloso per l’epoca e per l’epoca più
recente [dopo una fascia intermedia di tolleranza o di indifferenza].
All’oscuro di tutto, invece, continuavo
a inclinare, a parte i librini della B.U.R. [p.e. i racconti di Edgar Allan
Poe], verso gli albi di Topolino e Paperino, con più simpatia per Donald Duck,
andando ogni settimana a comprarli in edicola con la paghetta.
 Un personaggio: esuberante e
focoso, era riuscito a frequentare, ma per poco, un bordello che nel 1958
continuava l’attività in semiclandestinità in rima, essendo da poco entrata in
vigore la legge della senatrice Lina X [Greta]: una sorta di catapecchia a
ridosso del cavalcavia, o quasi sotto, e dello snodo stradale sul limitare
della zona industriale e dei cantieri navali. Le ragazze, secondo una mia
ricostruzione successiva, alle quali si era confidato, gli avevano consigliato,
fingendo di rimproverarlo e ridendo, di frequentarle di più, a modico prezzo,
lasciando perdere me che ero un bambino in pubertà, per quanto molto carino
d’aspetto. Parallelamente svolgeva da volontario [o semi-pagato, non so]
l’attività di sacrestano della parrocchia, cantava bene durante la messa, in
coro o da solista, aveva una bella voce, per di più assomigliava a Elvis
Presley, con il ciuffo con la brillantina: per visualizzare mentalmente questo
tipo di acconciatura-uomo le parole-chiave, ma postume, erano “grease” e
“rockabilly”. Paesaggi urbani, periferie da film neo-realista o il b/n di “Gioventù
Bruciata”, il film del 1955 con James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo [cfr. un
qualsiasi manuale di storia del cinema, forse nel mercato antiquario].
Un personaggio: esuberante e
focoso, era riuscito a frequentare, ma per poco, un bordello che nel 1958
continuava l’attività in semiclandestinità in rima, essendo da poco entrata in
vigore la legge della senatrice Lina X [Greta]: una sorta di catapecchia a
ridosso del cavalcavia, o quasi sotto, e dello snodo stradale sul limitare
della zona industriale e dei cantieri navali. Le ragazze, secondo una mia
ricostruzione successiva, alle quali si era confidato, gli avevano consigliato,
fingendo di rimproverarlo e ridendo, di frequentarle di più, a modico prezzo,
lasciando perdere me che ero un bambino in pubertà, per quanto molto carino
d’aspetto. Parallelamente svolgeva da volontario [o semi-pagato, non so]
l’attività di sacrestano della parrocchia, cantava bene durante la messa, in
coro o da solista, aveva una bella voce, per di più assomigliava a Elvis
Presley, con il ciuffo con la brillantina: per visualizzare mentalmente questo
tipo di acconciatura-uomo le parole-chiave, ma postume, erano “grease” e
“rockabilly”. Paesaggi urbani, periferie da film neo-realista o il b/n di “Gioventù
Bruciata”, il film del 1955 con James Dean, Natalie Wood e Sal Mineo [cfr. un
qualsiasi manuale di storia del cinema, forse nel mercato antiquario].
Molti anni dopo, avevo avuto
l’occasione di ricostruire il seguito della sua storia, mettendo assieme alcune
notizie, comprese quelle di un’amica d’infanzia e dell’azione cattolica, poi
diventata una suora a Roma, mi aveva regalato il ritaglio di un “coccodrillo”
nel piccolo riquadro della pagina di un quotidiano, con la riproduzione di un
ritratto per carta d’identità di Roberto X [Franz], dove ormai, benché
appesantito, assomigliava al Clark Kent dei comics prima serie. Ricordava
benissimo che eravamo stati molto affiatati e che trascorrevamo assieme i
pomeriggi di domenica, a parte le ore nella parrocchia e nell’oratorio, dove si
giocava con il calcio-balilla e a ping-pong. Poi si era sposato, su diktat del
suo confessore, con una ragazza [che da bambina, undicenne circa, figurava con
me, stessa età, in una fotografia, era figlia di un’amica di mia madre, nei
loro sogni ci vedevano adulti da fidanzati]. Aveva avuto cinque figli, fra
maschietti e femminucce, una vita irreprensibile, tutto casa lavoro chiesa e
sindacato, ma purtroppo era morto d’infarto a soli quarantaquattro anni, la
cardiopatia forse ereditaria e causata dall’obesità.
 |
| il quaderno da cui traggo spunto |
|
|
Quanto a me, invece, il suo
confessore aveva cercato di coprire la mia innocenza di ragazzino non ancora
entrato nell’adolescenza e con la media dell’otto e mezzo in terza media,
insinuando nelle prospettive dei miei genitori la mia inadeguatezza a
continuare gli studi, con un così modesto QI, per stroncarmi le parole nel
gargarozzo, acqua in bocca, e la possibilità di raccontare [di fatto, malgrado
la scarsa autostima, si sono svolti in modo contorto cambiando indirizzi almeno
un paio di volte, per fortuna poi proseguiti ottimamente, sia pure in ritardo,
dapprima con cambiamenti e ripensamenti da demente, fino alla maturità e alle
esperienze universitarie concluse bene fuori corso e al salotto di Madame X
[Greta] come promettente e anche all’università di Trieste, iscritto
direttamente al terzo anno [su quattro] e in seguito, pure, a Milano,
nell’ottica dell’educazione permanente e dell’autodidattica supportata da
docenti titolari in varie scuole per adulti e dagli amici con i quali mi
confrontavo, come salottieri e come peripatetici, nella vita vissuta. Un
periodare complesso, anche questo sperimentato, partendo da Lo-Li-Ta, la lingua
contro i denti. Ma soprattutto convinto di essere uno scrittore privato per tre
lettori, con pride, e uno Studente di Belle Arti a vita.
 Inoltre, per essere ancora più
sicuro di ridurmi al silenzio, il prete con la tonaca tradizionale, non in
clergyman [ricordate?], quello che puzzava, quello che non si lavava mai per
non commettere atti impuri da solo, insinuava tra i fedeli del quartiere gli
spifferi secondo cui di nascosto leggevo i libri proibiti che mi avrebbero
portato alla perdizione, OK, ma che soprattutto mi avrebbero spinto a
corrompere i loro figli. Mi sentivo avvolto, di colpo, in un’atmosfera ostile,
nella mia innocenza senza capire perché, così, a livello epidermico, nella
nebbia. Un po’ come era accaduto quindici anni dopo quando ero andato a
salutare Carlo X [Franz] e mi ero reso conto che da un giorno all’altro
cominciava a strattonarmi, metaforicamente, per indurmi a lasciarlo perdere,
mai visti e mai sentiti, mai conosciuti. In quella città di provincia stavo
diventando un ragazzino intoccabile, un giovanetto lebbroso, un poco di buono e
precocemente un assatanato: l’unico mio rifugio i libri, perfino di domenica,
senza più andare a messa, da solo in casa, quando i miei genitori allegramente
e giustamente partivano in gita da qualche parte con gli amici e i parenti.
Inoltre, per essere ancora più
sicuro di ridurmi al silenzio, il prete con la tonaca tradizionale, non in
clergyman [ricordate?], quello che puzzava, quello che non si lavava mai per
non commettere atti impuri da solo, insinuava tra i fedeli del quartiere gli
spifferi secondo cui di nascosto leggevo i libri proibiti che mi avrebbero
portato alla perdizione, OK, ma che soprattutto mi avrebbero spinto a
corrompere i loro figli. Mi sentivo avvolto, di colpo, in un’atmosfera ostile,
nella mia innocenza senza capire perché, così, a livello epidermico, nella
nebbia. Un po’ come era accaduto quindici anni dopo quando ero andato a
salutare Carlo X [Franz] e mi ero reso conto che da un giorno all’altro
cominciava a strattonarmi, metaforicamente, per indurmi a lasciarlo perdere,
mai visti e mai sentiti, mai conosciuti. In quella città di provincia stavo
diventando un ragazzino intoccabile, un giovanetto lebbroso, un poco di buono e
precocemente un assatanato: l’unico mio rifugio i libri, perfino di domenica,
senza più andare a messa, da solo in casa, quando i miei genitori allegramente
e giustamente partivano in gita da qualche parte con gli amici e i parenti.
Forse continuavo a essere fuori
fase ma, perfino in tarda età, da “artista da vecchio”, ogni tanto per ridere
ricordavo una canzonetta di Adriano Celentano, quella che trattava l’atmosfera
dell’estate e del silenzio del dì di festa in città: “Ora che mi annoio più di
allora… neanche un prete per chiacchierare… il pomeriggio è troppo azzurro…
sembra quand’ero all’oratorio con tanto sole, tanti anni fa, quelle domeniche
da solo…” e così via. Una decina di anni, se non sbaglio, successiva al
romanzino sintetico testé narrato, una digressione non richiesta o un
intermezzo tragicomico, atto a rallentare il flusso principale del mio
“contrattacco disarmato”.
Con una postilla, mi sia
concessa: il confessore di Roberto X [Franz], il sacerdote non profumato, dopo
avere messo a tacere tutta la nostra amicizia, che cominciava a trapelare con i
mormorii tipici di una città di provincia, di fatto tutti lo sapevano, tutti ne
erano informati, ma in TV non se ne parlava, per cui la cosa non esisteva,
aveva continuato con la sua routine piena di rimorsi, con la coscienza sporca,
anche questa puzzava, di sicuro, fino alla dipartita, quando si faceva aiutare
da una “perpetua”, che ormai, con l’evoluzione della lingua italiana, veniva
definita una “governante” o una “domestica” o ultimamente una “badante”:
qualcuno fra gli stanziali poco fedeli insinuava che fosse in realtà la sua
“fidanzata”, con un eufemismo per non dire un’“amante”, per non pagarle uno
stipendio, more uxorio. E, dulcis in fundo, post mortem, per i suoi meriti nel
campo del tradizionalismo, del conservatorismo e del centro-destra di destra
[più a destra del centro-sinistra di destra], le autorità gli avevano dedicato
una viuzza secondaria con una bella targa [non ricordo il suo nome], per poche
automobili in senso unico, fra palazzi di periferia e giardinetti con panchine
per i tossici del loco in attesa del turno per avere una dose di metadone in un
vicino ambulatorio dell’ASL [Azienda Sanitaria Locale], che però in un’epoca
precedente non esisteva o aveva una sigla diversa.
 Mi era stato raccontato un
aneddoto, ecco un raccontino sintetico nel raccontino già sintetico di suo,
alcuni decenni dopo quando avevo avuto l’occasione di passare da quelle parti
per un impegno e avevo incontrato qualcuno che mi ricordava dall’epoca della
mia amicizia con Roberto X [Franz], una cosa da poco, una storia anonima come
tante, uno dei tanti spifferi diffamatori che trapelavano in una città di
provincia, a volte giustamente, per vendetta e per contrattaccare, o per
divertimento e per sadismo intellettuale [don’t worry, gesti innocenti e
leggeri senza spargimento di sangue].
Mi era stato raccontato un
aneddoto, ecco un raccontino sintetico nel raccontino già sintetico di suo,
alcuni decenni dopo quando avevo avuto l’occasione di passare da quelle parti
per un impegno e avevo incontrato qualcuno che mi ricordava dall’epoca della
mia amicizia con Roberto X [Franz], una cosa da poco, una storia anonima come
tante, uno dei tanti spifferi diffamatori che trapelavano in una città di
provincia, a volte giustamente, per vendetta e per contrattaccare, o per
divertimento e per sadismo intellettuale [don’t worry, gesti innocenti e
leggeri senza spargimento di sangue].
Un ragazzo bello come un Antinoo,
bello come il sole in primavera, di buona famiglia, ubbidiente e studioso, con
una vita del tutto normale [nel senso di “senza caratteristiche particolari
della personalità”, essendo ancora in via di formazione], purtroppo un giorno
era incappato nella droga leggera, una scappatella, una bravata, la cosa stava
diventando sempre più lecita [non era l’inizio fatale, come veniva insinuato,
per continuare con una razione da iniettarsi nelle vene con una siringa non
sempre di fatto mono-uso]. Frequentava l’oratorio e il campetto adiacente
chiuso da alte inferriate, non so perché ma nell’ascoltare mi veniva in mente
una fiaba di Oscar Wilde, quella del “gigante egoista” e del suo giardino [a
distanza di anni nel mio immaginario era un “orco”], per giocare a calcetto e a
pallavolo. Ma al parroco con la tonaca nera mai fresca di bucato era giunta una
soffiata da una beghina o da un tirapiedi, quelle personcine che Gesù Cristo in
persona avrebbe definito “sepolcri imbiancati” frustandoli di brutto. Da un
giorno all’altro l’aveva escluso dalla parrocchia, non lo faceva più entrare
nemmeno per una partita con gli amici, che lo chiamavano chiassosi e allegri da
dentro il recinto, sospettato di corromperli, sospettato e condannato per
l’eternità.
 |
| locandina del film Lolita, versione originale |
Il povero ragazzo bello come un
Antinoo, bello come il sole in primavera, ci era rimasto male, si chiudeva
sempre più in se stesso, la psiche degli adolescenti e dei giovani a volte è
insondabile come una lingua mai decifrata e scoperta su una lapide affiorata da
un lago in secca, dall’alveo di un fiume con acqua stagnante, essendo
alimentato da una sorgente a singhiozzo. Si pubblicavano tanti saggi di
specialisti, con copertine accattivanti, ma nella vita quotidiana non servivano
quando venivano prese le decisioni irrevocabili a loro insaputa. Gli archeologi
moderni studiavano quelle vestigia, dette “dell’epoca del mouse grigio”,
ipotizzando nuove teorie, vedendo i resti di statue che rappresentavano grandi
topi su bellissimi piedestalli, ma in frammenti sparsi a terra, code, corpicini
senza zampe, musetti deliziosi, forse erano gli idoli di un’antica civiltà
sconosciuta.
A questo punto aveva davvero
cominciato a frequentare i tossici conclamati, consumatori e spacciatori,
emaciato e invecchiato, finché sotto i venticinque anni un giorno era stato
trovato morto sulla panchina di un giardinetto, un’overdose [d’amore] e via,
con la siringa ancora infilzata sul braccio, là dove passava la strada
asfaltata e dedicata al parroco che tanto aveva fatto per la crescita umana e
culturale del quartiere, così stava scritto sulla segnaletica. Dietro le
quinte: risolini, risate. Un inverno gelido più del solito. Di notte si udivano
gli sghignazzi e gli schiamazzi di gruppi di giovani che si rincorrevano,
scherzando, sulla via ghiacciata.
E Marte Herlofs, nel film “Dies
Irae” di Carl Theodor Dreyer, l’anziana donna accusata di essere una strega,
braccata dai cacciatori suoi compaesani [forse più giovani, forse invidiosi],
smaniosi di linciarla addolcendo l’inseguimento con un refrain ossessivo [“devi
morire sul rogo… devi morire sul rogo”]: si rifugiava in una casa attraverso
una porticina secondaria, come una tana, cercando la protezione di un pastore
luterano, convinta di salvarsi ricattandolo e sapendo che aveva scagionato una
seguace di Satana per opportunismo [per sposarne la giovane figlia], essendo
l’esistenza il bene più prezioso e finché c’era la vita c’era la speranza.
Con varianti: il suo Witch Pride, però, la spingeva a
sfidare il potere e a confessare convinta di farla franca, tra le lacrime e
tacitamente implorando la pietà. Risultato, la scena: la signora avanti con gli
anni, inerme, indifesa, legata su una scala a pioli, la fune solo intorno alla
base dei seni flaccidi e alle gambe per permettere al regista di inquadrarla
mentre portava istintivamente le braccia in avanti per proteggersi dalle fiamme
nel momento in cui gli addetti con un lungo bastone biforcuto la spingevano in
avanti sulle fiamme della pira, su un prato grigio come gli sterrati amati
dagli eroi nel millennio in cui sempre più le parole da sinonimi diventavano
contrari.
I giardinetti abbandonati e pieni
di cartacce e bottiglie di plastica accartocciate, il grande parco urbano dove
in fine agosto, passando dal gelo al sudore, e viceversa, una sera vagavo lungo
i vialetti illuminati dalla luce fioca dei lampioni. Nessuno, come me, prendeva
una boccata d’aria dopo la cena che non c’era stata, i grandi cespugli sui
prati neri, gli alberi, lo stagno, tutto continuava nella sua inutilità e nella
sua immobilità, nell’afa, con la dominante dei riflessi acidi che, se fosse
stato un romanzo, avrei potuto definire “lividi”, quasi gli stilemi cromatici
di una psichedelia spenta, e se io avessi alzato lo sguardo di poco,
controvoglia, avrei notato alcuni pipistrelli nel loro faticoso volo a zigzag.
Infine, seduto su una panchina [sopportando a malapena l’enorme spillo che mi
trafiggeva le tempie da una parte all’altra], un altro passeggiatore solitario
gironzolava pentendosi di non essere andato al cinema, ammesso che ce ne fosse
uno già aperto dopo la pausa estiva.
Forse era vero: eravamo animali
sociali, non occorrevano tanti studi filosofici per constatarlo, restando al di
qua del pensiero astratto, bastava la pratica. In piedi di fronte a me, mi
aveva indirizzato un saluto banale con un sorriso altrettanto ovvio: “Non c’è
nessuno in giro. Sono ancora tutti in vacanza, in ferie”. Me ne restavo in silenzio osservando alcuni
mozziconi di sigarette sul vialetto sterrato, quasi sotto la panchina a
listelli di legno verniciato con il colore verde, senza pensare alla “nausea”,
all’essere e al nulla, tantomeno alle “radici di un castagno”, un albero che
davvero mi stava di fronte pochi metri in là, vegetando. La citazione
dettagliata da Jean-Paul Sartre avrebbe appesantito la digressione. Varcare la
soglia della follia, quella mite, quella disarmata, avrebbe fatto percorrere la
propria esistenza in una sequenza onirica, in un certo senso abbreviandola?
Meglio: accorciandola, in una dimensione temporale assai relativa. Non sarebbe
più stato necessario aggiungere altri sistemi e altri anti-sistemi, per quanto
divulgati in frammenti, per lo più in stile aforismatico. Sottraendosi allo
sforzo, con ottimismo, di ideare una propria visione in formule linguistiche
sottoposte a variazioni personali, così l’animo avrebbe potuto dispiegarsi
spigoloso ma senza tirarla troppo per le lunghe.
Lo immaginavo euforico mentre
raccontava qualcosa cercando di coinvolgermi in una conversazione casuale sul
più e meno. A un certo punto lo avevo guardato in faccia e lo vedevo serio, di
colpo: reagivo come sempre mi veniva spontaneo, sorridendo a chi mi rivolgeva
la parola, per carattere e per buona educazione [con l’uso di una maschera sul
volto]. A questo punto aveva saputo esprimersi con il tono giusto, rivelandosi
una persona colta, incuriosendomi con la sua incisiva invadenza: “Come mai così
triste, se posso chiedere?”. Un gentleman al cento per cento non avrebbe mai
osato incrinare la privacy di uno sconosciuto, nemmeno vedendolo in piedi sul
parapetto di un ponte mentre si accingeva a buttarsi nel Tamigi, ma il
forestiero, che parlava perfettamente la lingua italiana… suo padre in origine
era di quelle parti, poi emigrato a Londra, si trovava per qualche giorno in
periferia da parenti, ecco perché si chiamava Giovanni X [Franz], il suo modo
di porgermi un biglietto da visita nel presentarsi come in un’epoca del lontano
passato, una ventina d’anni più di me, nato e cresciuto nell’UK, aveva studiato
là dalla scuola elementare fino a diventare un docente universitario di
letteratura inglese e di letterature comparate.
La saudade, diceva, dal latino
“solitudo”, era uno stato d’animo paragonabile alla nozione baudelairiana di
“spleen”, non esistevano consigli per togliersela di dosso, forse sarebbe
bastato il monito frivolo del poeta francese, citato con approssimazione:
“énivrez-vous de vin, de poésie ou de vertu, mais énivrez-vous”. Non c’è anche
“énivrez-vous d’amour…?”. No. E così
via. In seguito eravamo diventati amici, fra i tanti amici effimeri, cartoline
d’auguri a Natale, qualche mia scappata nella sua città, Manchester [da Londra,
dove venivo ospitato da Frank X] [Franz], ogni tanto anche in Italia, qualche
telefonata, un suo libro con la dedica autografa ricevuto per posta, aveva
curato un carteggio di non ricordo quale scrittore con Eleonora Duse [avevo il
volume cartonato in una scatola in un magazzino], finché un giorno il suo amico
danese, con il quale viveva, con un biglietto laconico me ne aveva annunciato
la morte improvvisa.
Più vita, leggere meno, me lo
ripromettevo quando fuori pioveva, era un inverno umido più che gelido, o non
abbastanza da definire quei giorni “i giorni della merla”, nel mio studiolo,
però, i propositi si alternavano con gli spropositi. Con alcune eccezioni, gli
autori moderni e contemporanei cominciavano ad annoiarmi, almeno quelli che
passava il convento e il convento era la grande editoria, si davano arie da
intellettuali perfino i librai solo perché le personalità del loco [i critici e
gli intenditori aggiornati e i giornalisti] andavano nel loro negozio a
comprare i volumi esposti di piatto come scatole di cioccolatini.
Effettivamente, mi sentivo traviato da due saggi. Innanzitutto il volume di
Mario Praz, “la carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica”,
letto e riletto in una delle tante edizioni Sansoni, come una Bibbia, la Bibbia
del giovane assatanato, del ribelle desideroso di aggiornarsi in vista del
1968, di cui ignorava l’avvicinarsi, precedendolo di una decina di anni perfino
prima dei tempi dei Beatles.
Poi, più in sordina, più noto
negli ambienti in procinto di delocalizzarsi in quelli accademici: Italo
Siciliano, “il romanticismo francese [da Prévost a Sartre]”, Sansoni, 1964
[meno incline ad appassionarmi, tanto per citare uno scrittore italiano, ad
Antonio Fogazzaro e al suo “piccolo mondo antico”]. In quell’atmosfera volevo
restare. Mentre si cercava di inquadrarmi in qualcosa di remunerativo e più
serio sapevo con lucidità particolareggiata che, da ragazzo traviato, stavo
scegliendo il cosiddetto “salto nel buio”, le dimensioni in cui la mia psiche
contorta avrebbe trovato il suo spazio, uno spazio pieno di specchi dove avrei
vagato in un labirinto, fregandomene di sapere se ci fosse o no una via
d’uscita.
Ma i tempi cambiavano e ormai
anch’io, come Gustave Flaubert, nel mio piccolo pensavo “Madame Bovary c’est
moi”: disintossicarsi, osservare la realtà del mondo. Si stava delineando qualche
cambiamento, là, nel mio studiolo. Il 18 gennaio di quello stesso anno una nota
di diario mi convinceva in modo particolare, non tanto per il suo contenuto,
ormai ripetitivo, ma per la sua brevità e soprattutto per lo stilema che mi
piaceva tanto, l’incipit con un gerundio: “Trovandomi in una situazione
psicologica caotica”. Punto. Mi ripromettevo il divertimento, il “primum
vivere, deinde philosophari”. Ma non tanto la vita come opera d’arte et
similia. Comunque evolvessero le cose prevaleva l’introverso, l’introspettivo,
incline a restarmene in casa. E subito dopo, la stessa data, una lettera di
quattro pagine e mezza indirizzata a Adriano Spatola, completamente cancellata
in modo accurato, in tutta probabilità dopo averla trascritta con la macchina per
scrivere, non ero in grado di affermare se spedita o no.